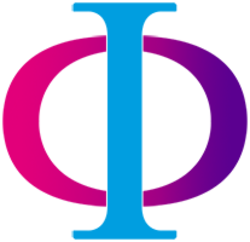Ivan Falardi, regista e fotografo è stato corrispondente negli anni ’70 da New York per il programma Pop Corn ed ha accettato di raccontare a noi di Seven Art quel periodo di libertà estrema e folle.
A quell’epoca tutto o quasi era permesso agli artisti. Arte, creatività e rinnovamento erano un tutt’uno.
Ivan Falardi ha vissuto al Chelsea Hotel, un edificio storico dell’800: “All’epoca in cui ci ho vissuto”, ci ha raccontato: “era un hotel modesto, già allora monumento nazionale”; “si trova sulla 23rd West, tra la settima e l’ottava al 222”.
Come mai è diventato così importante tanto da essere considerato monumento nazionale?
Perché molti artisti, poi divenuti famosi, vivevano lì. Era un luogo in cui succedeva di tutto e quindi posso affermare di aver vissuto a pieno quel periodo artistico americano. Il Chelsea è stato un luogo che ha visto nascere e morire tanti personaggi…Vi abitarono Bob Dylan, Patty Smith, Leonard Cohen che fece una canzone dedicata all’Hotel. Vivevano o erano passati dal Chelsea: Janis Joplin, Édith Piaf, Jimy Hendrix, i Pink Floyd, Stanley Kubrick, Sid Vicious dei Sex Pistols, la cui fidanzata fu trovata morta per overdose nella sua stanza.
Tra quelle mura Arthur C. Clarke scrisse “Odissea nello Spazio”. Anche Andy Warhol abitò al Chelsea dove concepì la sua Factory; in questo periodo della sua vita non era ancora famoso e stava tentando di farsi conoscere nonostante il suo carattere scontroso. Avevo avuto modo di entrare in contatto anche con Isabella Rossellini, Rosa Fumetto e l’Avvocato Agnelli, che ovviamente frequentava ambienti più altolocati.
Può raccontare l’aria che si respirava al tempo?
In Italia, accanto alla sperimentazione come cercavamo di praticare ad esempio a Pop Corn, nascevano programmi decisamente più commerciali e un po’ scontati. Negli Stati Uniti, a New York in modo particolare, si respirava un sincero senso di libertà, ma anche una buona dose di ossessione per il denaro, come è sempre stato da quelle parti del resto. In America vali se guadagni. Ricordo una sera in cui incontrai in un locale Al Pacino con il suo paltò lungo e nero che non tolse per tutta la serata; la prima cosa che mi chiese fu quanto guadagnavo. Mi chiese “Questa roba (il tuo lavoro), cosa ti porta? Quanto ti fa guadagnare?”
Lei ha frequentato molto Paolo Buggiani, lo scultore italiano del ghiaccio e del fuoco.
Si, eravamo amici. Con Paolo abbiamo improvvisato una performance sulla 5th Avenue nel cuore di Manhattan, quando incendiammo un’auto prefigurando le gesta del Minotauro (tutto ripreso dalle telecamere).
Anche Keith Haring faceva parte di quell’allegra compagnia. Fu proprio Buggiani a presentarmi questo ragazzo dai riccioli rossicci che di notte imbrattava con i suoi graffiti i vagoni della metropolitana. Mi aveva colpito quest’arte che sfrecciava sui binari e Keith si prestò per realizzare un video capace di valorizzarla.
Cosa volevate dimostrare?
Eravamo curiosi di sapere che cosa sarebbe successo. La New York del tempo ti spingeva a realizzare i tuoi sogni. Se avevi qualcosa da dire o da fare la potevi realizzare, la città ti apriva le porte. Tutto era possibile per gli artisti.
Era al centro di New York anche la grande gallerista italiana Marisa del Re.
Oh si, al pari della galleria straordinaria di Leo Castelli, punto di riferimento per coloro che sono diventati grandi come Pollock, o Mark Rothko.
In sostanza ci fu una coniugazione della cultura italiana che accolse nel rinnovamento quella dei giovani artisti americani?
Gallerie come quella di Leo Castelli sono state importanti per la Pop Art, non solo americana. A quel tempo i galleristi erano molto diversi, erano promotori culturali in primis, non erano solo commercianti, proponevano cose nuove e investivano per far crescere gli artisti nei quali credevano.
E la Pop Art cosa ha comportato?
Uno sdoganamento dell’arte ritenuta fino ad allora elitaria, per farla diventare accessibile a tutti o quasi. Con la raffigurazione e ripetizione ossessiva dei beni di consumo, ad esempio, e dei cliché dell’immaginario americano si voleva ribadire che tutto o quasi poteva diventare arte. Molte le immagini tratte dalla pubblicità, dai fumetti, dalla TV, dai film che si producevano a Hollywood.
Secondo lei qual è la differenza tra l’arte alternativa di quel periodo e l’arte di oggi?
Senza addentrarmi sulle differenze estetiche tra l’arte di quel periodo e quella di oggi che ci porterebbe troppo lontano voglio solo indicare un’attitudine. Non c’è più la solidarietà, l’idea della corrente che univa un po’ tutti. Oggi la ricerca è squisitamente personale. Negli anni ’70 la Factory di Warhol era una fucina di idee e di realizzazioni a più mani. Per esempio, Little Angel, che a quei tempi aveva solo tredici anni, era diventato famoso in poco tempo, molto vicino alle tematiche di Keith Haring, ma altrettanto velocemente era caduto in disgrazia, anche per un abuso eccessivo di sostanze stupefacenti. Ora stanno cercando in qualche modo di recuperarlo.
Come vive oggi l’arte Ivan Falardi?
Facendola. Dipingendo mediante l’utilizzo della macchina fotografica. Sono un performer del colore in movimento, un Light Painter. Grazie al buio metto in scena la luce, il mio “inchiostro”, e le sue declinazioni. Una forma di manipolazione del colore che non finisce mai di sorprendere, di stupirmi poiché il risultato è solo in parte programmabile e, come tale, imprevedibile, tanto meno scontato. Così come la vita, del resto.
La più recente installazione che ho realizzato è EYES 206 Points of View.
206 occhi disseminati nell’Area Archeologica di Genova.
La prossima sarà realizzata sull’isola di Gallinara di fronte ad Albenga, poi sarà la volta di Fabrica a L’Havana e quindi a Milano nel cosiddetto Pirellone.